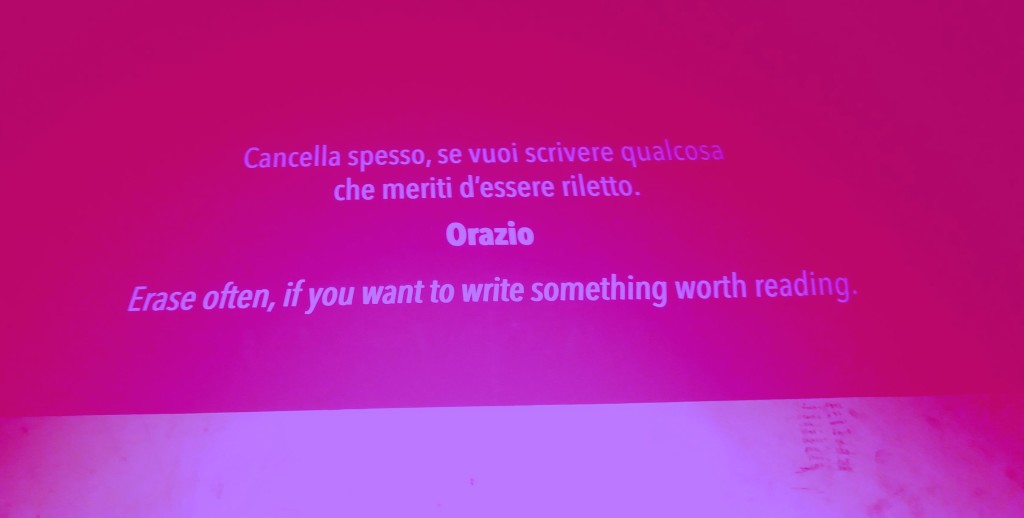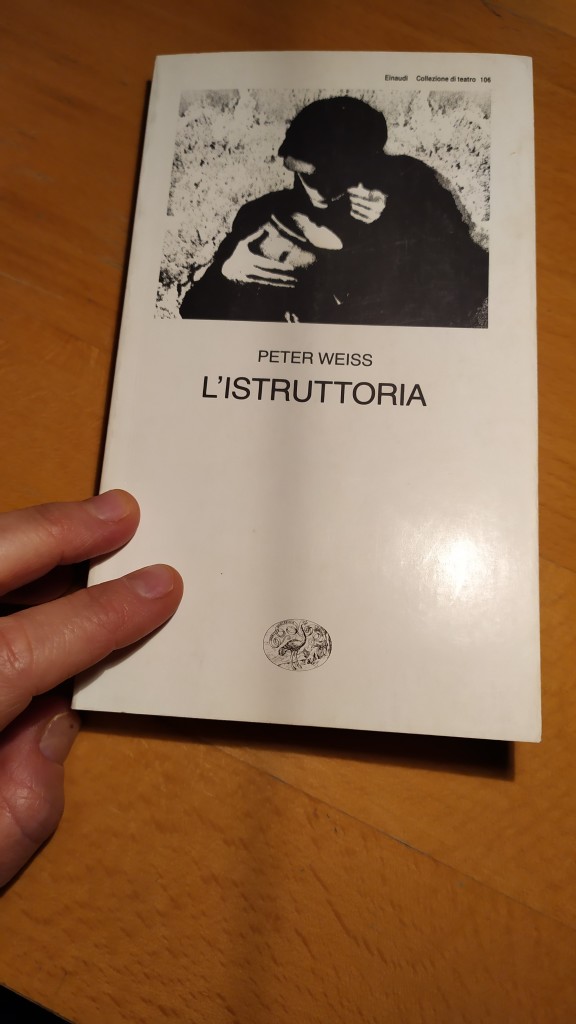Parco di Yosemite, settembre 2009
Parco di Yosemite, California, settembre 2009. La prima volta in quello stato, la quarta negli Sati Uniti. Viaggio itinerante, con l’idea di includere alcuni luoghi specifici, e poi di giorno in giorno prenotazioni telefoniche per i pernottamenti successivi in motel e case. Almeno nei viaggi itineranti, per quanto possibile, le tappe e gli orari da rispettare non fanno per me. Abbiamo sempre viaggiato così.
Dopo un paio di giorni decidiamo di visitare un’area più isolata della super turistica valle, ricca di straordinarie bellezze (soprattutto per noi europei) ma forse un po’ troppo organizzata. Prenotiamo un bed and breakfast dall’altra parte del parco (che significa alcune centinaia di chilometri). Salutiamo il motel e i simpatici procioni che stazionano davanti alla nostra porta e ci mettiamo in viaggio. Bellissima e impervia la strada (anche se dopo alcune strade montane della Corsica e un paio del Marocco, posso dire che l’asfalto ci cullava dolcemente). In quel momento sono io al volante e lui segue la cartina (di carta). Un ranger ci ferma per dirci che per via di un grosso incendio la strada è bloccata. Gli indico sulla cartina il posto che vogliamo raggiungere in tre ore e lui tra il serafico e il disincantato risponde “disdica la stanza, non si passerà da lì per un po’, volendo potete prendere l’altra strada ma allungate parecchio e ci vorranno sette, otto ore. Potete prendere sempre questa strada qui, ma nell’altra direzione e andare su, è molto bello, li qualcosa trovate”. Un po’ generico, ma invitante. Torniamo indietro e puntiamo a una zona molto centrale del parco, decisamente remotissima. Poi un cartello “White Wolfe Campground” nel cuore di una foresta. I cartelli gialli continui, indicano che la zona è molto frequentata dagli orsi.
Campeggio, all’epoca, super spartano (oggi non saprei). Ci dicono che se vogliamo hanno qualche tenda, tipo quelle da campo, montate con la stufa a legna dentro. Sono il loro equivalente dei bungalow. Le regole sono rigidissime. Dobbiamo firmare una liberatoria per gli orsi, dobbiamo (come ovunque nei parchi), chiudere tutto ciò che sprigiona odore nel cassonetto di ferro con gancio di chiusura a prova di orso laureato, multe stellari per chi lascia fuori anche un tubetto, i generatori per l’elettricità si spengono alle 22, portatevi la pila dietro, quello è il cesso, cena fino alle 21 tipo minestre e carne nella casetta di legno di Zio Zeb, reception chiusa riapertura alle 6, e tanti saluti. Come dev’essere. Ruvida foresta, turismo da depliant inesistente. Ceniamo nella casetta di Zio Zeb insieme a un paio di persone conosciute lì, i ragazzi dello staff sono gentili, la roba è buona e quando usciamo il cielo pulsa di migliaia di stelle. Spuntano tra i varchi dei rami delle alte conifere. I generatori si spengono, i fiochi lampioni muoiono definitivamente e fa abbastanza freddo. Ricorderò per tutta la vita l’odore della stufa dentro il bosco, nel silenzio maestoso della notte. Usciamo dalla tenda per andare in bagno che è a circa cinquanta metri. Scopriamo che anche le porte dei cessi sono assicurate da un gancio di sicurezza. Ci aspettiamo fuori prima di rientrare in tenda. Lui cammina davanti a me con la torcia al minimo puntando il fascio verso terra. Improvvisamente a pochi passi da noi, alla nostra destra, un ruglio di tutto rispetto. Un orso ci avverte della sua presenza. Lo sentiamo muoversi, a pochi metri, ma ignoriamo – diciamo pure pietrificati – in quale direzione. Sappiamo in generale che è buona cosa è evitare di puntare la torcia su musi vari. Mio marito nel viaggio e nella vita è coraggioso quanto me, in questo ci assomigliamo, e mi dice cerchiamo di andare avanti, non corriamo sennò potremmo essere fottuti.
Sono i cinquanta metri più lunghi della mia vita. La sensazione di essere rientrati al sicuro in tenda non riesce a tranquillizzarci. Sentiamo il vagolare di piccoli ospiti che strusciano contro il bordo, piccoli animaletti del bosco, ma nessuno ci toglie dalla testa che possa essere ancora lui. Nel settore delle tende individuali, in lontananza, gruppi di ragazzi ridono e scherzano. A un certo punto fanno un sacco di rumore con le pentole e intimano con vari fuck qualcosa a un orso di andarsene. Fatico molto ad addormentarmi. Quando finalmente crollo anche io in un sonno profondo come la notte, vengo svegliata brutalmente da un tonfo metallico, tremendo e ostinato. Un orso sta saltando sopra a uno dei cassonetti di ferro con il lucchetto a prova di orso laureato. Da una tenda stanziale come la nostre, a venti metri da noi, un tipo si incazza, urla e si mette a fare rumore.
Riprendo sonno, e poi subito la luce del mattino ci sveglia dolcemente. Apriamo la tenda e c’è profumo di caffè dalle tende vicine. Noi non avendo alcuna stoviglia portata dall’antica Europa, ci prepariamo e adiamo a fare colazione alla casetta di Zio Zeb. Sono più o meno le 6.30 e mi porto dietro la macchina fotografica. Andiamo nel punto in cui l’abbiamo sentito e troviamo la sua orma. Una bella fettona di zampa. A colazione, chiedo a uno dei ragazzi che ci porta le meravigliose pancake con acero a golate se secondo lui abbiamo rischiato. “No, secondo me, no. Io quando vengo a lavorare qui, li incontro sempre nei sentieri di giorno, e allora faccio un sacco di rumore e loro se ne vanno”, dice scrollando le spalle. “Non penso che volesse aggredirvi, voleva solo dirvi: sappiate che siete a casa mia. Avete fatto comunque bene a muovervi come avete fatto, in ogni caso non bisogna mai perdere il controllo con questi animali, di solito non sono aggressivi, sempre che non abbiano i cuccioli, certo di notte è più complicato…”. Aggiunge scrollando le spalle, sorride e se ne va.
Tra quel “di solito”, “non penso” “sempre che non” e la scrollata di spalle passa il concetto di imprevedibilità, che noi umani sembriamo non tenere in considerazione in un sistema vile, molto vile, che ha fatto del binomio paura-sicurezza la spada di Damocle e che io spesso faccio fatica ad accettare. Per questo devo stare nella natura, appena posso.
Due anni fa siamo tornati in California, Oregon, Utah, Arizona. Viaggiando sempre nello stesso modo. Abbiamo fatto tante escursioni, anche in zone piene di orsi, piene di branchi di elk, ma non avevo alcun timore. Perché due immagini si erano scolpite a mia difesa, quella scrollata di spalle, e il volto di una donna, penso almeno settantenne, che avevo conosciuto, sempre in quel viaggio successivamente all’episodio dell’orso. Era con la nipotina vicino a un laghetto e stava guardando il panorama. Ci chiede da dove veniamo, gli raccontiamo degli orsi, lei mi fa vedere due piccoli pentolini legati allo zaino, li libera dall’elastico e li sbatte l’uno contro l’altro: “Me li porto sempre dietro nei sentieri, basta fare così” e si fa una risata.
Torno al presente, al video circolato sul web un paio di settimane fa. Luogo: monti del Trentino. Alle spalle di un bambino in gita con la famiglia sopraggiunge un orso di mole considerevole. Il padre del bambino cammina a ritroso e fornisce indicazioni al figlio e riprende per un paio di minuti con il cellulare tutta la scena. Una minoranza di opinione sostiene che siano stati i genitori a organizzare l’avvicinamento dell’orso per regalare l’incontro al bambino appassionato di plantigradi. Questo non lo so.
Risparmio parole sull’ossessione da ripresa video, ormai endemica e giustificata per raccogliere ogni singola emozione; risparmio ogni sillaba sulla nuova concezione del ricordare che si va perpetrando perché esistono analisi meravigliose sul narcisismo di questa nostra epoca attuale. Le statistiche, come molti di noi sanno, sono incoraggianti sulle scarse possibilità che un orso attacchi e sbrani. Qualche volta però succede di essere vittima di semplici aggressioni, o di diventare una polpetta fra le fauci della fiera. Come qualche anno fa in India, quando un ragazzo del posto sceso dall’auto decide di farsi un selfie davanti a un orso ferito e questo lo sbrana. Il tutto ripreso in diretta dai telefonini delle persone che assistevano alla scena urlando.
Credo che occorra tenere presente il pericolo emotivamente molto alto di sbagliare l’approccio. Perché se la paura è la nemica potentissima del nostro secolo, lo è anche la disinvoltura. E che cosa più di un telefonino fa della disinvoltura la protagonista indiscussa? I grandi animali sono archetipi ancestrali della paura. Sono immaginari non addomesticabili, ed in parte è giusto che rimangano tali, per ridimensionare la fastidiosa visione eccessivamente romantica e naif della realtà animale di cui i social web sono portatori molto insani e inesatti. Solo l’esperienza diretta e la conoscenza, la consapevolezza del giusto atteggiamento possono garantire un rapporto differente tra natura ed esseri umani.
Non mi interessa accusare con scrittura di fiele coloro che hanno svolto le riprese del ragazzo. È facile, scontato.
Sconcertante è il fatto che fare una ripresa con telefonino sia considerato addirittura imprescindibile. Ma l’orso non lo sa. Questo è il punto. L’orso non lo sa.
L’immaginario non addomesticabile, quando da film della mente diventa reale non crea necessariamente nuove fobie, ma ci rende consapevoli che l’uomo è sì il super perfido predatore del pianeta, ma nella natura selvaggia è per fortuna, spesso e in molti luoghi ancora solo un ospite. Un ospite ridicolo, se una simile esperienza deve essere riprodotta da una telecamera. Telecamera di sorveglianza del proprio coraggio. Ma l’orso non lo sa.