
Seattle, 2017 (Foto di Silvia Dacomo)
Tutto era cominciato nella prima metà degli anni Settanta. Mio padre affrontava la crisi di mezza età con fantasticherie. In linea con il suo carattere ironico, curioso, e per molti versi stravagante. I miei genitori non sono mai stati ricchi, ed entrambi – friulana lei, piemontese lui – provenivano da famiglie tutt’altro che danarose, men che meno possidenti di terreni, alloggi e quant’altro.
Il 1975 fu l’anno della casa di legno.
Per motivi di lavoro, mio padre entrò in contatto con un tizio del cuneese che commercializzava case prefabbricate di legno, ossia dacie russe. Così, nel giro di poco tempo casa nostra cominciò a essere invasa da progetti di case, del tutto simili alle casette della Lego con cui avevo giocato tanti anni prima, ma in fondo neppure troppo diverse dalle case nella prateria di Zeb Macahan, l’eroe di Alla conquista del West. Ecco rulli di carta oleata grigia con le planimetrie tracciate in nero, e brochure con le foto delle case in vendita. Tutto prefabbricato, tutto legno sano, tutto semplice. E soprattutto economico. Ricordo, dopo cena, i progetti srotolati sul tavolo di cucina, mio padre che illustrava con il fuoco sacro della meraviglia e noi con gli occhi incollati a seguire le sue dita che percorrevano recinti, verande meravigliose, mansarde da gnomi, e finestre all’inglese divise in quattro quadrati.
“Mica andremo a vivere in una casa di legno, fuori città?”, gli chiedevo. Adoravo vivere nel nostro appartamento in affitto, dove ero molto felice. Un vicinato simpatico, ci conoscevamo ed aiutavamo tutti e soprattutto c’era tanto verde. Vicino a scuola, vicino al centro, vicino agli alberi, tanti alberi. “No, certo”, mi rincuorava lui. La dacia sarebbe stata una specie di seconda casa, per i weekend, a respirare l’aria buona della collina, nei boschi intorno a Pecetto. “Certo”, diceva, “non è molto pertinente come stile, ma se si trova il terreno giusto sarà un paradiso”. Mia madre, con un pezzo di Mitteleuropa nelle vene, ripeteva la solfa che un pessimista è uno che ha conosciuto da vicino un ottimista, e ci metteva del suo: “Una casa di legno? Ma non siamo in Svizzera, non siamo in America, non siamo in Svezia, non siamo in Russia, non siamo..” e ripercorreva la geografia dei paesi traboccanti di abeti.
Pecetto è un paese sulla collina a pochi chilometri da Torino circondato da boschi e frutteti, fino ai primi del secolo meta di gite domenicali di operai e artigiani (tra cui i miei nonni), con un’economia basata sulla coltivazione delle ciliegie. Quando ero ragazzina, i terreni costavano poco, c’erano case coloniche bellissime ma in stato di degrado e piene di muffa, che se solo uno avesse avuto i soldi per restaurarle sarebbero valse un patrimonio.
Ma, una casa di legno non sarebbe mai valsa un patrimonio. Si sarebbe immediatamente deprezzata. Certo mio padre ne era consapevole, ma era un investimento per noi, una casa che con qualche sacrificio forse ci saremmo potuti permettere. Così “prefabbricato” divenne l’aggettivo vincente, un leitmotiv della nostra storia familiare che univa leggerezza, facilità e fantasie di weekend agresti. Ma mia madre non ne volle sapere. Partì all’attacco con il fatto che la località era umida (vero) e “d’inverno cosa ci andiamo a fare?”. Era un sacrificio economico da sostenere. E poi la manutenzione. E poi, magari, l’eccessivo isolamento. E poi i rischi incendi, “una porta che si butta giù con una spallata”, e altri ottimismi di questo genere. Così a poco a poco la fantasia si sgonfiò come una meringa mal riuscita, e il progetto non continuò.
Ma continuò nella mia testa.
Tutte le sere sfogliavo quella brochure con le foto delle case e fantasticavo. Le colline intorno a Pecetto erano diventate la campagna inglese, o la prateria del West americano, o le case dei film di Bergman (che mia madre mi dispensava in giovane età – grazie a lei, però, amo il cinema). La veranda era il luogo dove stare gli amici, leggere, la mansarda dove sognare tra le nuvole, ascoltare i miei dischi, guardare l’alba e il tramonto, la sala un posto dove mio padre avrebbe potuto collocare un vero pianoforte verticale di seconda mano e non la tastiera elettronica con la quale strimpellava jazz a casa dopo il lavoro, il giardino un posto dove prendere il sole d’estate con mia madre. Penso di avere consumato quelle foto con una specie di raggio laser che i miei occhi di bambina invasati di immagini abitative esotiche puntavano su quelle pagine. A me piaceva rossa con le finestre bianche quadrettate, quella con la veranda costava di più, ma vuoi mettere? Mio papà concordava.
Accantonato il progetto, nessuno tornò indietro. Tuttavia mi resi conto che le case di legno mi piacevano davvero, mi erano sempre piaciute, le avevo sempre amate, nei film, nella realtà vera come la montagna, dove mio fratello affittava a Gressoney una casa Walser con venti amici. Una casa che crepitava ad ogni respiro ed era magnifica. E le avrei amate sempre di più.
E poi… qualche anno dopo, arrivò la Sila. Una delle estati con i miei in viaggio verso la Sicilia, ci fermammo a far tappa nella meravigliosa regione calabra. Visitammo il parco silano e un villaggio famoso per (indovinate!) le case di legno dai colori pastello immerse nei boschi. Ma allora era vero! Si poteva vivere in una casa di legno fiabesca, allora forse anche a Pecetto avremmo potuto! Niente, sogno infranto.
Ma ne sopraggiunsero altri di sogni, sempre di matrice paterna: ci fu l’anno della pasta fatta assolutamente in casa, l’anno dei centrifugati di carote, l’anno di Khrishnamurti, l’anno del possibile acquisto di una casa-cubo in Sicilia, totalmente da ristrutturare e soprattutto comoda da gestire da qui (!), e ancora l’anno del possibile acquisto di una casa prefabbricata a forma di iglù, sempre in Sicilia, progettata da una ditta israeliana che io, mio padre e mia madre visitammo per caso. Nel corso di una passeggiata infatti, mio padre rivolse al proprietario di fatto una vera e propria intervista sulla geniale struttura, che a parte ricordare un ufo, era davvero freschissima e meravigliosa. Mio padre si entusiasmava, si informava ma poi veniva sempre a patti con la realtà. I miei sublimarono le favole di seconde case, e raggiunta una più sicura tranquillità economica iniziarono a viaggiare parecchio in Italia e in Europa.
In età adulta, nel corso dei miei viaggi negli Stati Uniti, ho visto tante case di quel tipo, tutte diverse. Ci ho dormito dentro, ho salito le scale ricoperte di moquette, ho ascoltato i procioni correre nel sottotetto e dormito in mezzo ai boschi del Maine. Ecco poi le case di legno degli immigrati russi in America, le case rifugio di certi eremiti dell’Oregon, isolatissime. Per non parlare delle palafitte di alcune località della baia di San Francisco. O le case di Ballard, il quartiere svedese di Seattle. Sono tutte altrove. Sono colorate, anche maldestramente, non rifinite. Eppure sono ancora l’immagine di quella brochure che ogni tanto si ripresenta a cinquantatrè anni.
Per ironia della vita, da sei anni abito sulla collina torinese a pochi chilometri dalla città, in un piccolo appartamento di un condominio di tre sole unità circondato dai boschi, da un rio, a sette minuti di auto dal cartello stradale “Pecetto”, località dove per altro mi reco spesso. In un prato vicino a casa mia, hanno trasformato forse un capanno per attrezzi di legno scuro in una dépendance, o forse in una casetta per ospiti. Sotto un ciliegio giapponese. In aprile faccio hamami, vicino a quella stradina sterrata.
Ed ecco che ho ripensato subito alle dacie. Mi immagino in una di queste casette, costruita su un minuscolo terreno vicino a casa, ma proprio in mezzo al bosco, senza servizi, senza wi-fi, solo per andarci a scrivere, leggere. Oggi sono più vecchia di quanto fosse mio padre allora, e più di allora adoro la natura e sicuramente più di un tempo anche l’isolamento. Non che dove vivo manchi.
Sublimare i sogni non è difficile, basta riscriverli. Essere consapevoli che certe cornici di vita che in modo surreale ci seguono, ci rincorrono, o si piazzano davanti a noi di tanto in tanto come foto, e a volte in modo struggente ci perseguitano, arredavano già le pareti della nostra mente.
Sono le cose, le persone, i luoghi che qualcuno che ci amava e che amavamo ci ha fatto amare davvero.

collina torinese, pressi rio Martino, 2019






















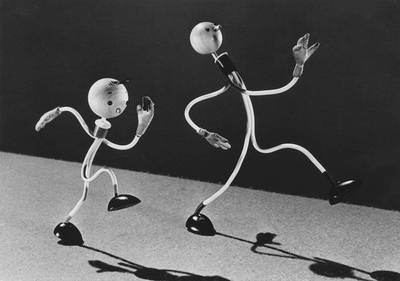












![DSCN2379[1097]_1](http://www.silviadacomo.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/DSCN23791097_1-1024x768.jpg)










